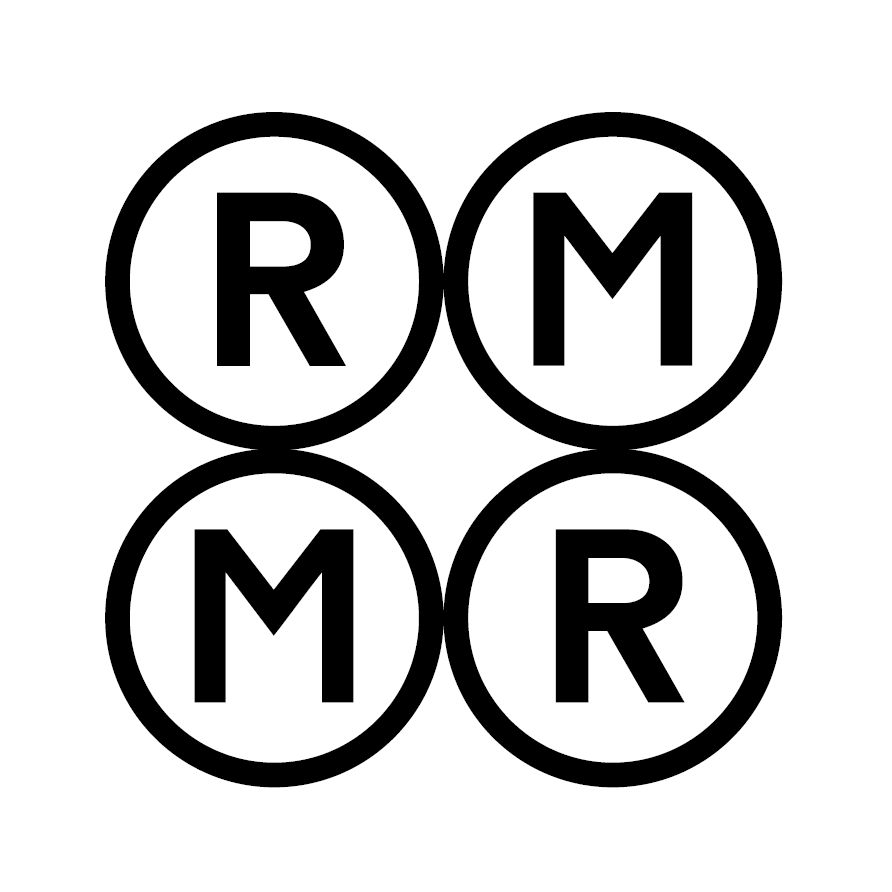C’è una forza che opera nel nostro tempo, ma non la troverete sulle prime pagine dei giornali economici o tra le slide patinate dei grandi convegni finanziari. È una forza che non urla, ma agisce. Che non specula, ma produce. Che non cerca unicorni, ma comunità. È l’economia sociale, un approccio che intreccia impresa, giustizia sociale e sostenibilità. Sostenendo una visione che negli ultimi dieci/quindici anni si è affermata anche in ambienti e istituzioni fino a ieri refrattarie a ogni visione che non ponesse il profitto al primo posto. E che oggi − proprio oggi, che la transizione ecologica sembra scendere nelle priorità della politica − rischia di risentire del nuovo clima.
Un piccolo segnale in questa direzione viene dal recente smantellamento dell’unità dedicata all’economia sociale nella Direzione generale per il mercato interno dell’Unione Europea (DG GROW). Non si tratta solo di un cambio di organigramma: è il segnale di una visione ancora troppo parziale e settoriale di ciò che l’economia sociale rappresenta. Come se fosse solo un affare da politiche sociali. Ma l’economia sociale è molto di più: è l’energia rinnovabile dell’economia europea. E l’Europa, questa energia, oggi non può permettersi di sprecarla.
Partiamo dai fatti. Le imprese sociali, le cooperative, le mutue, le fondazioni, i consorzi e le organizzazioni del terzo settore sono già protagonisti dell’economia europea. E lo sono con un’attitudine da economia circolare. Recuperano beni, reintegrano persone, rigenerano territori. Producono beni e servizi, ma soprattutto producono senso, valore condiviso, resilienza. Mentre grandi imprese si affannano a ripulirsi la reputazione con campagne di greenwashing, le realtà dell’economia sociale fanno davvero economia circolare: trasformano scarti in risorse, esclusione in occupazione, marginalità in innovazione.
Nel settore tessile, ad esempio, dove la pressione a un acquisto compulsivo ha distrutto ogni logica ambientale, le cooperative sociali raccolgono, selezionano e rivendono tonnellate di vestiti usati, creando lavoro per persone fragili. Nella filiera agroalimentare, le aziende dell’agricoltura sociale difendono la biodiversità e combattono il caporalato. Nell’edilizia, sperimentano modelli di bioarchitettura e housing sociale. Nell’energia, promuovono le comunità energetiche rinnovabili. E lo fanno non per moda, ma per missione.
E allora perché ignorarle? Perché limitare l’economia sociale solo a una questione di welfare o occupazione protetta? Perché non vederla invece come leva strategica per la transizione industriale, ecologica e digitale?
L’economia sociale è imprenditoria a tutti gli effetti, ma con una bussola diversa. Non cerca la massimizzazione del profitto, ma l’equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale. È l’anello mancante tra gli obiettivi della transizione ecologica e le politiche industriali dell’UE. È la prova vivente che un altro modo di produrre è possibile. E che funziona.
La Commissione europea, attraverso l’Action Plan per l’economia sociale, aveva cominciato a riconoscerlo. Aveva aperto un dialogo trasversale tra Direzioni, messo in moto meccanismi di coprogettazione, stimolato riforme nazionali. Ma ora rischia di fare un passo indietro. Di rallentare il passo, spegnere proprio mentre si corre la maratona della transizione.
In un mondo che brucia (letteralmente), dove le disuguaglianze aumentano, i servizi pubblici arrancano e le risorse naturali si esauriscono, abbiamo bisogno di modelli economici che rigenerino. Che mettano al centro le persone e non solo i capitali. Che operino nei territori, ascoltino i bisogni, costruiscano fiducia. L’economia sociale lo fa da sempre, senza aspettare i grandi summit sul clima o le linee guida ESG.
È tempo di smettere di considerarla un’appendice “buonista” del sistema economico, e venga riconosciuta come infrastruttura strategica. Non basta un piano d’azione: serve una visione sistemica, un commitment istituzionale trasversale, una governance robusta.
Il paradosso è lampante: proprio mentre servono modelli resilienti, capaci di affrontare crisi multiple — ambientale, sociale, democratica —l’economia sociale rischia di tornare in secondo piano, spinta ai margini da un nuovo ordine di priorità che pensa di poter riconquistare competitività e produttività senza curarsi della tenuta del tessuto sociale.
Eppure, durante la pandemia, chi ha garantito la coesione sociale? Chi ha mantenuto vivi i servizi essenziali nei territori? Chi ha retto l’urto delle disuguaglianze? Le risposte non sono arrivate dalle big tech o dalla finanza, ma dalle reti cooperative, dalle imprese sociali, dalle comunità organizzate.
Le entità dell’economia sociale non sono beneficenza organizzata. Sono impresa, ma con un’anima. Sono innovazione, ma con coscienza. Sono competitività, ma con equità. In una parola: sono futuro. Ma un futuro che mette in discussione il dogma della crescita fine a sé stessa. Che dimostra che si può fare impresa senza distruggere, accumulare senza escludere, prosperare senza sfruttare. E questo intimidisce. Perché se funziona non ci sono più scuse per non cambiare.
In copertina: immagine Envato