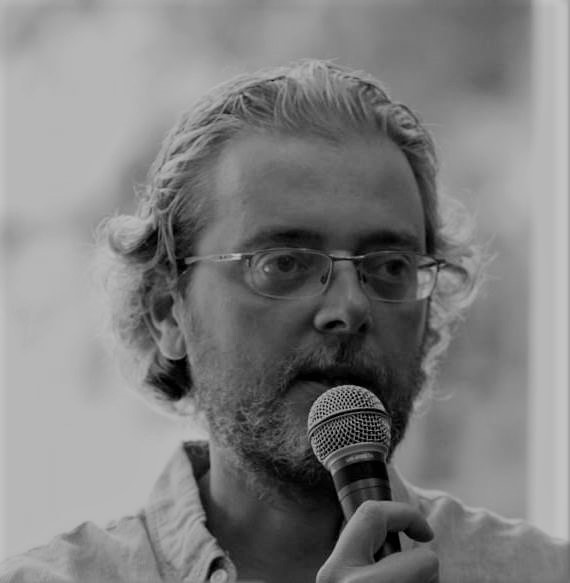La crisi climatica e le sfide sistemiche poste dal riscaldamento globale richiedono un ripensamento della formula democratica e una rimodulazione della partecipazione. Un esempio interessante arriva dalla Francia, dove gli obiettivi dell’Agenda 2030 sono stati presi molto sul serio, come dimostrano molte iniziative più o meno recenti: dal Piano di sobrietà energetica alla strategia per eliminare la plastica monouso, dalle iniziative per contrastare l’obsolescenza programmata alle modifiche nel campo della mobilità.
Chi compone la Convenzione cittadina per il clima
Un ruolo fondamentale nel dare un nuovo indirizzo alla politica di Parigi lo ha rivestito la Convenzione cittadina per il clima (Convention Citoyenne pour le Climat), costituita nell’ottobre 2019 dal Consiglio economico, sociale e ambientale (Conseil économique, social et environnemental, CESE) su domanda dell’allora primo ministro Édouard Philippe.
I 150 membri di questa commissione sono stati sorteggiati fra la popolazione francese tenendo conto di sei criteri: sesso, età, titolo di studio, categoria socio-professionale, tipo di territorio e zona geografica. L’istituto Harris Interactive che ha effettuato il sorteggio non ha selezionato i partecipanti all’assemblea in base alla loro esperienza, ma lo ha fatto in modo da avere un campione rappresentativo della società francese.
Per nove mesi i membri della Convenzione cittadina hanno provato a rispondere a una domanda non semplice: “Come ridurre almeno del 40% rispetto al 1990 le emissioni di gas serra da qui al 2030, nel rispetto della giustizia sociale?”. Nel corso dei lavori, l’assemblea dei cittadini ha potuto contare sul sostegno di un Comitato di governance composto di esperti tecnici e giuridici e di professionisti della partecipazione e della deliberazione collettiva.
I risultati
Frutto del lavoro dell’assemblea sono le proposte della Convention Citoyenne pour le Climat pubblicate per la prima volta il 26 giugno 2020 e successivamente aggiornate e integrate il 21 gennaio 2021. Prima di redigere il testo con le conclusioni, i membri dell’assemblea si sono confrontati con amici, vicini, concittadini, associazioni ed eletti delle istituzioni locali e nazionali.
“Questi incontri” si legge nel documento contenente le 149 proposte, “ci hanno permesso di raccogliere tutta l’esperienza e il sentito dei nostri interlocutori, in modo da confrontare le nostre riflessioni alla realtà quotidiana ma anche alle questioni economiche, geografiche, politiche e sociali di ogni territorio.” Una delle premesse nella compilazione del documento programmatico è stato l’equilibrio fra le realtà metropolitane e quelle delle regioni più periferiche, comprese quelle d’oltremare.
Nata in epoca pre-pandemica, in contemporanea con l’apice delle proteste dei gilet gialli e con l’ascesa mediatica di Greta Thunberg, la Convention Citoyenne pour le Climat ha provato a rispondere a una serie di istanze di matrice socio-ambientale provenienti dal basso suddividendo il suo rapporto finale in cinque grandi aree tematiche: consumi, produzione e lavoro, mobilità, edilizia e alimentazione.
Le proposte
In un’ottica di ripensamento dei consumi l’assemblea ha individuato come prioritari l’obbligo di indicazione dell’impronta di carbonio su prodotti e servizi, la regolamentazione della pubblicità in modo da disincentivare il sovraconsumo, la limitazione del sovraimballaggio e dell’utilizzo di plastica monouso. Punto cardine del capitolo su produzione e lavoro è lo sviluppo delle filiere della riparazione, del riciclaggio e della gestione dei rifiuti. Altrettanto imprescindibili sono l’inserimento del bilancio del carbonio all’interno dei bilanci contabili e un radicale ripensamento delle modalità di produzione, stoccaggio e redistribuzione dell’energia.
Nel campo della mobilità le richieste volte a una maggiore sostenibilità sono molteplici: lo sviluppo di alternative all’utilizzo dell’auto individuale, la riprogettazione della viabilità per permettere nuove abitudini negli spostamenti, la creazione delle condizioni per un ritorno all’utilizzo del treno al di là dell’Alta Velocità, la riduzione della circolazione dei mezzi pesanti, l’impegno delle imprese a una riorganizzazione dei percorsi casa-lavoro dei propri impiegati.
Nel campo dell’edilizia la priorità è rappresentata dall’obbligo della ristrutturazione energetica degli edifici entro il 2040, dalla riduzione dei consumi energetici nei luoghi pubblici e privati e dalla lotta contro il consumo del suolo. Infine, il capitolo relativo all’alimentazione propone l’implementazione delle filiere corte, una negoziazione dei prezzi più equa per gli agricoltori, un’ulteriore riduzione degli sprechi alimentari, lo sviluppo di pratiche agroecologiche e di una pesca a basso impatto ambientale.
La legge Clima e resilienza
Parte delle proposte della Convention Citoyenne sono confluite nella legge Clima e resilienza (Climat et Résilience) del 22 agosto 2021 che è stata organizzata secondo le cinque aree tematiche del rapporto prodotto dall’assemblea. Con un modello mutuato da precedenti esperienze di Islanda, Irlanda e Regno Unito, l’assemblea dei 150 membri sorteggiati come campione della popolazione francese ha dimostrato come un’altra democrazia sia possibile e, forse, necessaria per affrontare la crisi climatica con un approccio indipendente dalle leggi del mercato e attento al bene comune e agli equilibri ecosistemici.
Immagine: Pexels