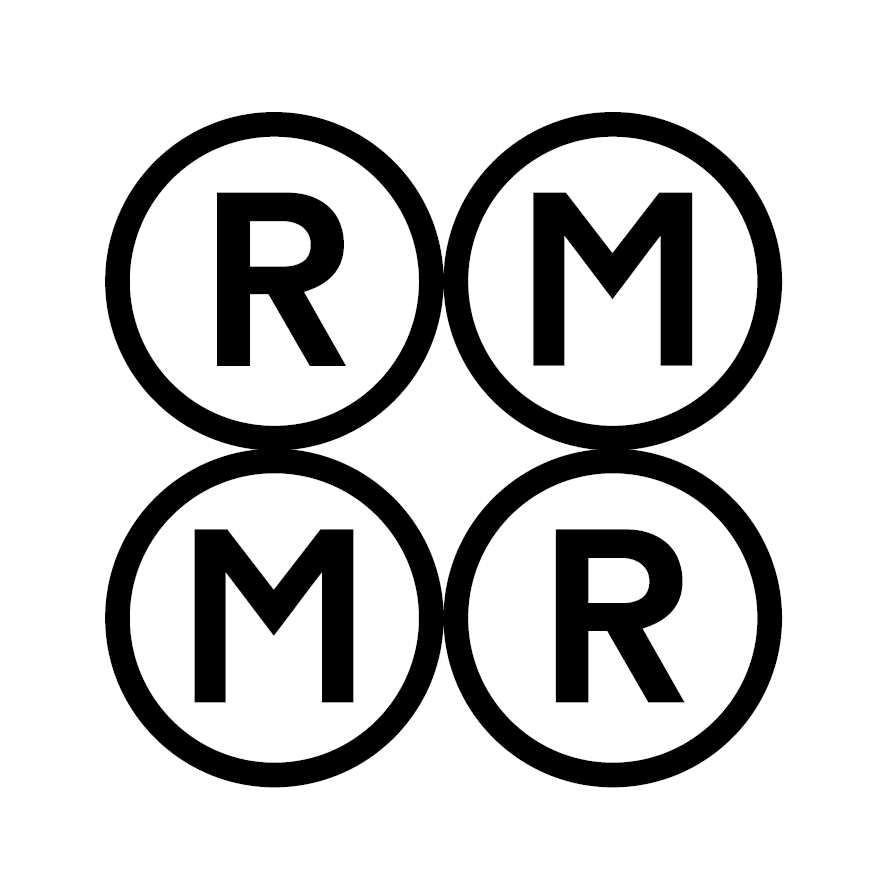Questo articolo è disponibile anche in inglese / This article is also available in English
Con la morte di Papa Francesco si spegne una delle voci più autorevoli del nostro tempo nella lotta per la giustizia climatica e la difesa dell’ambiente. Jorge Mario Bergoglio, il “Papa venuto dalla fine del mondo”, ha fatto della difesa della Terra e dei poveri il cuore del suo pontificato. Un faro per credenti e non credenti.
A partire dalla scelta del nome, Francesco − che evocava “l’uomo che ama e custodisce il Creato” − Bergoglio ha segnato un punto di svolta nella storia della Chiesa e del rapporto tra religione e ambiente. “Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri! Per questo mi chiamo Francesco, come Francesco da Assisi”, disse nella sua prima conferenza stampa. Un nome che conteneva già tutto: povertà, pace, dialogo interreligioso, amore per la Terra.
Il suo impegno ambientalista ha preso forma concreta nel 2015 con la pubblicazione dell’enciclica Laudato si’, la prima nella storia della Chiesa interamente dedicata alla crisi climatica. In quel documento il Papa articolava con rigore teologico e morale l’urgenza di una “ecologia integrale”: un’idea di ambiente che tiene insieme natura, giustizia sociale, dignità umana e cultura. Un manifesto per altro pubblicato nello stesso anno dell’Accordo sul clima di Parigi.
“La crisi ecologica, insieme alla distruzione di buona parte della biodiversità, può mettere in pericolo l’esistenza stessa della specie umana”, aveva avvertito Francesco parlando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ma non si era fermato alla denuncia. Aveva convocato in Vaticano le big oil – Eni, Chevron, Conoco, Exxon, Bp e Blackrock – per un confronto senza precedenti su energia e responsabilità ambientale.
E poi ancora: il sinodo panamazzonico del 2019, l’esortazione Querida Amazonia, il progetto di introdurre l’eco-peccato nel catechismo, la denuncia dell’“ecocidio come crimine contro l’umanità”. Papa Francesco ha fatto della lotta al cambiamento climatico una dimensione spirituale, un’urgenza morale universale. Senza ambiguità, senza edulcorazioni: “L’uso delle armi nucleari, così come il loro semplice possesso, è immorale”, dichiarava in tempi di nuove tensioni globali.
Nel 2023, nella Laudate Deum, seconda tappa del suo magistero ecologico, ha aggiornato il suo grido d’allarme: “Sono costretto a fare queste precisazioni, che possono sembrare ovvie, a causa di certe opinioni sprezzanti e irragionevoli che trovo anche all’interno della Chiesa cattolica. Ma non possiamo più dubitare che la ragione dell’insolita velocità di così pericolosi cambiamenti sia un fatto innegabile: gli enormi sviluppi connessi allo sfrenato intervento umano sulla natura negli ultimi due secoli”.
Il suo è stato un insegnamento che travalica i confini confessionali. Ha parlato alle giovani generazioni, ha incontrato Greta Thunberg e Bono Vox, ha condannato apertamente il “negazionismo climatico” e la “vorace ricerca di guadagni a breve termine delle industrie inquinanti”. Ha invocato una “nuova architettura finanziaria” per rispondere alle esigenze del Sud del mondo e agli stati insulari colpiti dai disastri climatici.
In uno dei suoi ultimi interventi pubblici, aveva ricordato che i bambini più poveri del pianeta – quasi un miliardo – vivono in aree ad “alto rischio climatico”, e che questo rende “una colpa grave” l’inerzia della politica e dell’economia. Le sue parole, sempre più dirette, sono diventate un lascito: “La distruzione dell’ambiente è un’offesa contro Dio”.
Francesco è stato il Papa delle “prime volte”, e tante di queste riguardano l’ambiente. In un mondo spaccato da conflitti e disuguaglianze, ha avuto il coraggio di porre la domanda più scomoda di tutte: “Stiamo lavorando per una cultura della vita o una cultura della morte?”. Se c’è una lezione da raccogliere oggi, è che proteggere la Terra non è solo un dovere politico o economico: è un atto di fede nell’umanità. La Casa comune ha perso un difensore instancabile. Resterà la sua voce, più attuale che mai.
In copertina: Papa Francesco tra la folla, fotografato da Ashwin Vaswani, Unsplash