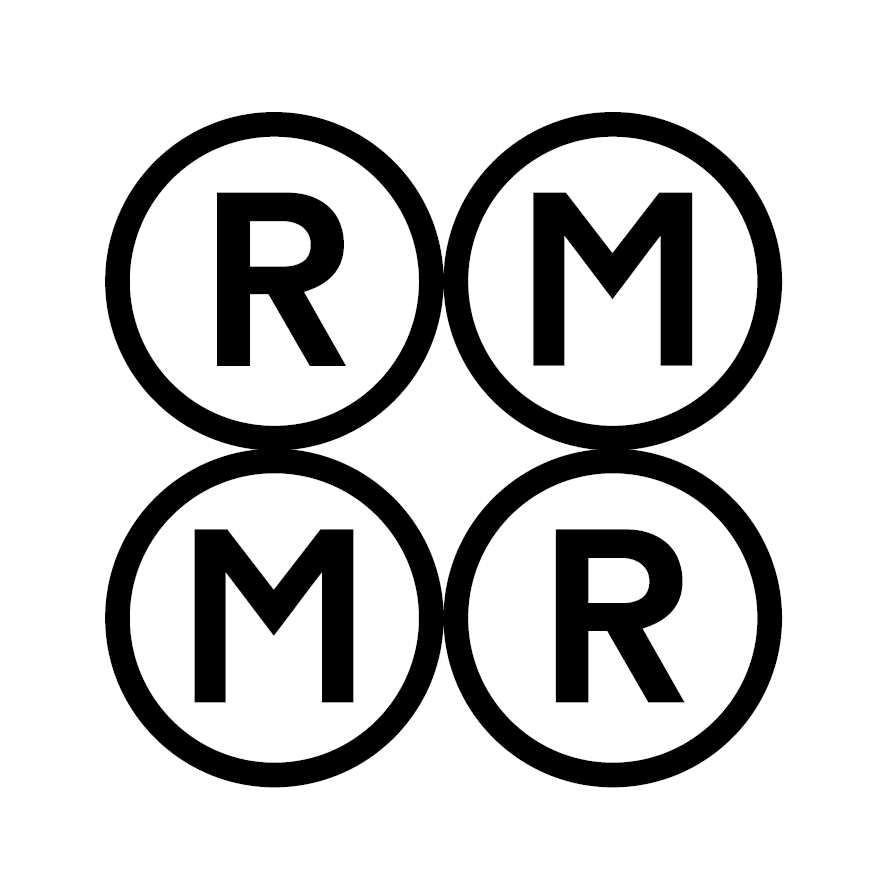La sezione Think Tank del numero 50 di Materia Rinnovabile, dedicato all’Energia, è particolarmente ricca e preziosa. Come sempre abbiamo riunito in una tavola rotonda virtuale alcune delle voci più autorevoli sui temi affrontati nella monografia. La transizione ecologica globale e il percorso verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio sono stati affrontati da diversi punti di vista, per delineare un quadro più completo possibile delle sfide, delle criticità e delle potenzialità che ci aspettano.
Partendo dalla politica, con la commissaria UE per l’energia Kadri Simson, al termine del suo mandato, passando per le tecnologie, le infrastrutture e le economie dell’energia con Francesco La Camera dell’IRENA e James Robb della North American Electric Reliability Corporation, per arrivare alla scienza e alla ricerca di frontiera con Pietro Barabaschi, direttore generale di ITER. Qui di seguito, un riassunto dei temi di cui abbiamo parlato. Le interviste complete le potete leggere su Materia Rinnovabile #50.
Kadri Simson: dare energia all’Europa
Durante i suoi cinque anni da commissaria per l’energia a Bruxelles, Kadri Simson ha dovuto affrontare uno dei periodi più complessi e decisivi della storia energetica europea, cimentandosi con l’impresa di tagliare le forniture di gas russo, traghettare le riforme del Green Deal nonostante le policrisi, rendere resiliente il mercato energetico senza trascurare gli obiettivi di decarbonizzazione.
“Il raggiungimento dei nostri obiettivi climatici sarà vantaggioso anche per i consumatori e per le imprese”, commenta. “I costi dell'inazione sarebbero semplicemente molto più alti di quelli dell'azione. Negli ultimi anni i cittadini di tutta Europa sono stati testimoni degli effetti devastanti del cambiamento climatico. È arrivato il momento di agire con decisione e investire nella transizione verde.” Tra passato, presente e futuro, Kadri Simson racconta a Simone Fant l’eredità di un mandato storico che ora volge al termine.
Francesco La Camera: garantire le materie prime per la transizione
Non sarà la scarsità di materie prime critiche, i Critical Raw Material (CRM), a frenare o addirittura impedire la corsa dell’umanità verso la triplicazione della capacità di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, portandola ad almeno 11 TW contro gli attuali 3,8 TW. Utilizzando nuove tecnologie emergenti, recuperando risorse grazie alla circolarità e aumentando l’attività di ricerca e sfruttamento minerario, sarà possibile trovare e trasformare la materia necessaria per l’impresa.
Minerali e terre rare che saranno trasformati in campi eolici e fotovoltaici, tecnologie di trasformazione in elettricità e idrogeno verde, accumulo energetico. Ma per riuscirci servono politiche industriali e commerciali per superare il controllo del mercato dei CRM da parte di poche grandi aziende e di pochi stati. E consentire ai paesi in via di sviluppo di avere una fetta più grossa dei ricavi. Questa è l’analisi di Francesco La Camera, dal 2019 direttore generale dell’IRENA (International Renewable Energy Agency), l’agenzia intergovernativa a cui aderiscono 168 stati, con sede negli Emirati Arabi Uniti, che ha il compito di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Roberto Giovannini lo ha intervistato per noi.
Pietro Barabaschi: il Sacro Graal dell’energia
Riprodurre l’energia delle stelle qui, sulla Terra. Per poi intrappolarla e utilizzarla. Per decenni gli scienziati si sono interrogati su come ricreare in laboratorio le condizioni che, sul Sole, determinano la fusione degli atomi di idrogeno e la loro trasformazione in elio, generando un’enorme quantità di luce e calore. Che l’esperimento sia realizzabile è in realtà cosa nota sin dagli anni Cinquanta, quando per la prima volta, nell’ambito della ricerca a scopi militari, la fusione venne utilizzata in un test della Bomba H.
Ma sfruttare l’energia di fusione – teoricamente illimitata e quasi senza scorie – a scopi civili presenta sfide ben più ardue, che partono dalla fattibilità delle tecnologie, per poi spostare lo sguardo molto in avanti nel tempo sull’affidabilità e scalabilità dei sistemi. Se i “record” sul guadagno netto energetico tramite fusione, annunciati ormai con una certa frequenza da vari reattori sperimentali, hanno rinvigorito la speranza di raggiungere il “sacro Graal dell’energia”, le tempistiche tuttavia continuano a essere imprevedibili. Ma questo non ferma l’interesse economico: negli ultimi anni gli investimenti privati nella ricerca sono aumentati, superando, secondo la Fusion Industry Association, i 6,2 miliardi di dollari nel 2022.
E cresce anche l’impegno dei governi, come dimostra il mega progetto ITER, acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor, che in totale dovrebbe ricevere 20 miliardi di euro in vent’anni da un consorzio internazionale di sette partner pubblici: Unione Europea, Cina, India, Giappone, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti (fino al 2023 c’erano anche Regno Unito e Svizzera). Per farsi raccontare gli obiettivi di ITER, Giorgia Marino ha raggiunto il direttore generale Pietro Barabaschi nel suo ufficio a Cadarache, nel sud della Francia, proprio sul sito dove sta sorgendo quello che sarà il più grande impianto per la fusione nucleare del mondo.
James Robb: un futuro ad alta tensione
L'interconnessione dei sistemi elettrici (bulk power system) è un pilastro fondamentale della transizione energetica. Le reti di trasmissione ad alta tensione non sono tuttavia infrastrutture monofunzionali, utili solo a scambiare energia elettrica tra diverse regioni geografiche, paesi o continenti in ottica di cooperazione. Griglie interconnesse favoriscono l’efficienza economica e consentono di superare su larga scala le sfide legate all'intermittenza delle fonti rinnovabili non programmabili come solare ed eolico, aumentando così la resilienza, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi energetici.
Questi tre ultimi punti, non a caso, sono il motto della North American Electric Reliability Corporation (NERC), autorità di regolamentazione internazionale senza scopo di lucro che serve quasi 400 milioni di persone in una giurisdizione che comprende gli Stati Uniti continentali, il Canada e la parte settentrionale della Baja California, in Messico. Un territorio enorme, disomogeneo tanto nell’orografia quanto nella densità di popolazione, che non smette di aggiungere nuovi livelli a una stratigrafia di infrastrutture ormai più che secolare. Un’evoluzione che oggi deve tenere conto dei nuovi bisogni, decarbonizzazione in primis, ma anche dell’evoluzione di rischi come cambiamento climatico e cybersicurezza. Giorgio Kaldor ne ha parlato con James Robb, presidente e CEO della NERC.
SCARICA E LEGGI IL NUOVO NUMERO DI MATERIA RINNOVABILE: ENERGIA
Questo articolo è disponibile anche in inglese / This article is also available in English