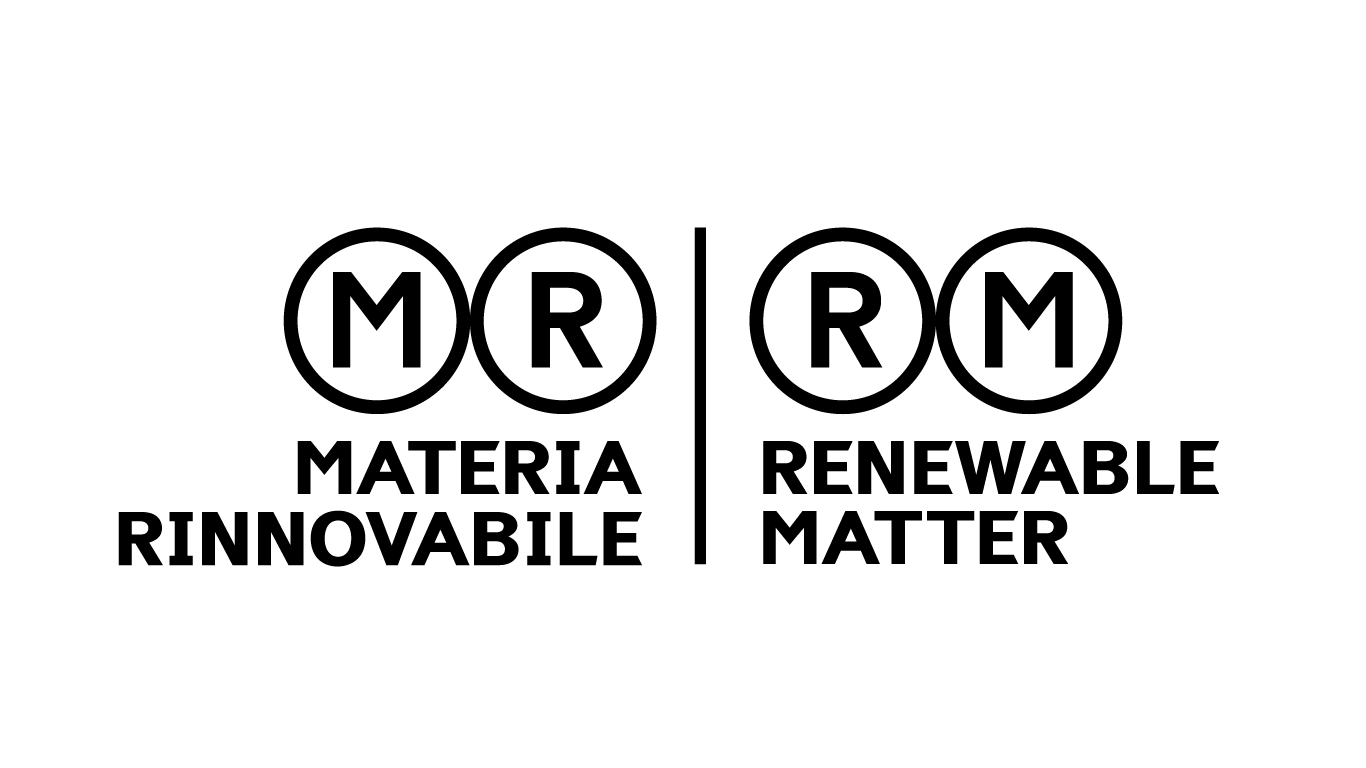Questa è la foto della metà oscura dell’economia circolare. I flussi che entrano nel circuito industriale, agricolo e urbano sono sotto la luce dei riflettori, ben pesati e misurati; i flussi in uscita attirano molto meno interesse. Quanta della materia rinnovabile viene davvero rinnovata? Quanta viene sprecata?
Conosciamo il nostro bilancio energetico fino all’ultimo chilowattora e non ci sfugge il numero esatto dei cellulari e dei chili di zucchero immessi sul mercato, ma non sappiamo dove finiranno i calcinacci dell’edificio che stanno abbattendo nel nostro quartiere o che fine faranno le bucce dell’arancia che stiamo mangiando.
Finora questa gerarchia di conoscenza è stata dettata da motivi ovvi: da una parte (in entrata) c’erano beni che valevano fatturati e posti di lavoro, dall’altra (in uscita) un ammasso informe di materia che il più delle volte costituiva solo un problema. Per decenni abbiamo pensato che il valore di una merce si azzerasse nel momento in cui per vari motivi (è rotta, non è più di moda, non piace) le sue funzioni venivano meno.
Ma i giudizi economici che avevano portato a pesare con diversa attenzione l’input e l’output del nostro sistema produttivo sono ancora validi? A questa domanda è difficile rispondere in modo netto perché il cambiamento è in corso: in alcuni settori l’economia circolare è più matura e conveniente, in altri meno. Il fatto stesso però che il processo sia stato avviato – e la normativa europea lo certifica – cambia il quadro e sollecita un adeguamento del sistema di misura in modo da avere gli strumenti per poter giudicare. Perché trovare un dato costa, ma può rendere se aiuta ad aumentare l’efficienza del circuito produttivo. Oggi alla vecchia (e sempre valida) necessità di controllare i danni prodotti da una cattiva gestione dei rifiuti si somma l’opportunità di incassare una parte dei vantaggi che l’Unione europea ha prefigurato nel Pacchetto sull’economia circolare: risparmi annuali per il settore produttivo pari a 600 miliardi di euro, 580.000 nuovi posti di lavoro, taglio del 2-4 % delle emissioni serra.
La Ellen MacArthur Foundation e il McKinsey Center for Business and Environment inoltre calcolano il peso dei nuovi stili di vita legati all’economia circolare. Per esempio oggi le auto europee passano in media il 92% del tempo ferme mentre lo sviluppo del car sharing e dei veicoli a più alte prestazioni ambientali può abbattere del 75% i costi per chilometro percorso. E i modelli di edilizia avanzata permettono di dimezzare i costi di costruzione. L’insieme di queste innovazioni vale al 2030 una crescita del 7% del Pil europeo.
Per questo è diventato ancora più importante porre le domande giuste per capire quello che manca nel monitoraggio delle sostanze che per alcuni sono scarti e per altri possono diventare risorse. Quanto è circolare l’economia italiana? Quanto siamo competitivi in questo settore? Quanti dei miliardi di euro di risparmio e dei posti di lavoro previsti dalla Commissione riusciremo a ottenere?
Materia Rinnovata, che dal prossimo anno misurerà la crescita dell’economia italiana basata sulla rinascita della materia, vuole mettere in evidenza il potenziale della seconda gamba della sostenibilità: l’uso intelligente della materia, cioè la lotta contro lo spreco di ciò che scorre davanti ai nostri occhi assumendo la forma di merce solo per una breve parentesi temporale.

A oggi mancano informazioni importanti sul destino dei materiali di scarto. Per quanto riguarda l’Italia c’è una parte del paese che si colloca nella fascia alta dell’Europa: in settori come gli imballaggi, gli pneumatici, gli oli usati la circolarità della materia è alta, i numeri affidabili e i vantaggi ambientali ed economici certificati. Ma parliamo di quantità che corrispondono a poco più di un decimo del flusso totale di rifiuti. Gli altri nove decimi che fine fanno?
I numeri che riguardano ampi settori dei rifiuti industriali e agricoli non ci raccontano con precisione il destino degli scarti. C’è una distrazione collettiva, una rimozione antica del problema. Se immaginiamo di chiedere a dieci persone a caso quale percentuale di rifiuti in Italia viene riciclata o recuperata, alcuni risponderebbero di non averne la minima idea, altri darebbero forse una risposta a due cifre, forse numeri che ruotano attorno al 40% perché l’unico elemento che con qualche continuità appare sui media è la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e questa percentuale si colloca sopra al 40%. Ma stiamo parlando degli imballaggi e di poco altro all’interno della sfera urbana. La percezione collettiva dei problemi (molto chiara) e delle potenzialità (molto nebbiosa) legati ai rifiuti è tutta lì: concentrata su una parte dei circa 30 milioni di tonnellate che complessivamente vengono dalle città, mentre il totale dei rifiuti è pari a circa 161 milioni di tonnellate.
Inoltre i rifiuti non vengono raccolti in maniera differenziata per far fare loro un giro turistico più bello (tra l’altro più lungo e dunque con maggiori costi energetici e ambientali). La contropartita di questo maggiore sforzo è data dai benefici derivanti dal riuso, dal riciclo, dal recupero energetico che a oggi, per alcune delle categorie interessate, devono arrivare al 50%, quota destinata rapidamente a salire con l’approvazione del Pacchetto europeo sull’economia circolare: un appuntamento non rimandabile anche per gli impegni presi sul fronte del cambiamento climatico e della crisi economica. Pensare di rispettare questi impegni guardando solo all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili vuol dire correre con una gamba sola.
Il potenziale di risparmio economico, energetico e ambientale che l’economia circolare può mettere a disposizione è formidabile. Secondo la Commissione europea se il 95% dei telefoni cellulari fosse raccolto, si avrebbero risparmi sui costi dei materiali di fabbricazione pari a oltre un miliardo di euro. Se si rimettessero a nuovo i veicoli commerciali leggeri, si risparmierebbero materiali per oltre 6,4 miliardi di euro l’anno e 140 milioni in costi energetici, riducendo inoltre le emissioni di gas serra di 6,3 milioni di tonnellate. Se partissero le politiche previste dal Pacchetto sull’economia circolare, si taglierebbe una buona parte degli sprechi alimentari che in Europa valgono 180 chili a testa ogni anno: un terzo del totale del cibo prodotto.
Cosa serve per rendere reali queste potenzialità? L’analisi dei numeri disponibili e di quelli mancanti offre un’indicazione: ci sono due blocchi di settori governati da dinamiche diverse. Nel primo figurano i comparti industriali che si sono organizzati, anche sul piano della contabilità, in base al principio della responsabilità estesa del produttore (Epr, Extended producer responsibility) e offrono perfomance di riciclo e di recupero già buone o in miglioramento. Nel secondo blocco troviamo i settori in cui l’interesse all’innovazione nel recupero della materia è scarso, le informazioni sul destino degli scarti frammentarie.
Finora si è prestata poca attenzione alle differenze tra questi due blocchi perché il tema della rinnovabilità della materia è diventato da poco d’attualità e perché le definizioni usate sono incomprensibili ai più (si va da Epr a Compliance scheme): sarebbe opportuno cominciare a parlare di “sistemi collettivi” o “sistemi responsabili”. Ma l’idea di base è potente: smettere di pensare a ciò che non viene più usato come a un rifiuto, qualcosa che improvvisamente diventa sgradevole e deve essere allontanato in fretta.
Ogni anno utilizziamo enormi quantitativi di materia che vengono prelevati dalla natura con grande impiego di energia, di acqua, di territorio e inseriti in un ciclo complesso di trasformazione; un percorso lungo il quale, sotto la forma di merci, ci rendono dei servizi, per esempio permettendo di leggere questo scritto. Possiamo disinteressarci delle conseguenze della nostra azione di acquisto, dell’impatto che la materia che abbiamo comprato avrà sulla nostra stessa vita o su quella dei nostri vicini? E se ne può disinteressare chi con quell’oggetto ha realizzato i suoi guadagni? La risposta dell’Unione europea è un no netto: c’è una responsabilità comune e diversificata. Chi immette la materia sul mercato si assume la responsabilità del suo intero ciclo di vita, compreso il momento in cui la carta o lo schermo su cui state leggendo queste parole cesserà di essere utile e sentirete il bisogno di sbarazzarvene. Chi ha comprato una merce si assume la responsabilità dell’atto con cui si libera dell’oggetto che non intende più utilizzare.
Questa nuova etica è più onerosa per le imprese? Nello scenario adottato da Bruxelles, in cui si dipingono le potenzialità delle nuove “miniere” urbane e industriali create dal guardare con occhi diversi i rifiuti, i vantaggi superano gli svantaggi perché le aziende guadagnano in competitività e in immagine, dunque anche in profitti. Un’impresa moderna ha interesse ad assumersi la responsabilità della materia che ha movimentato sia perché ottimizza le risorse sia perché altrimenti si creerebbe una frattura tra il suo punto di vista e quello dell’acquirente. E l’acquirente potrebbe decidere di non comprare merci o servizi forniti da chi guadagna sulle vendite dei prodotti mentre la collettività paga gli oneri derivanti dallo smaltimento di quegli stessi prodotti.
Per la verità è quello che succede nel campo dell’energia visto che i combustibili fossili assicurano floridi profitti alle compagnie petrolifere e comportano, secondo le Nazioni Unite, costi per la collettività pari a 5.000 miliardi di dollari. Ma proprio questo ritardo sul fronte dell’energia offre alla materia la possibilità di prendere una posizione di testa nella sfida eco(logica)-eco(nomica) per la sostenibilità e dunque per il nuovo mercato. La convenienza ambientale c’è. Proviamo a misurare quella economica. E a ipotizzare strade per raggiungere obiettivi più convenienti per tutti.
Short Report Materia Rinnovata. Quanto è circolare l’economia: l’Italia alla sfida dei dati, giugno 2016; www.materiarinnovabile.it/pubblicazioni