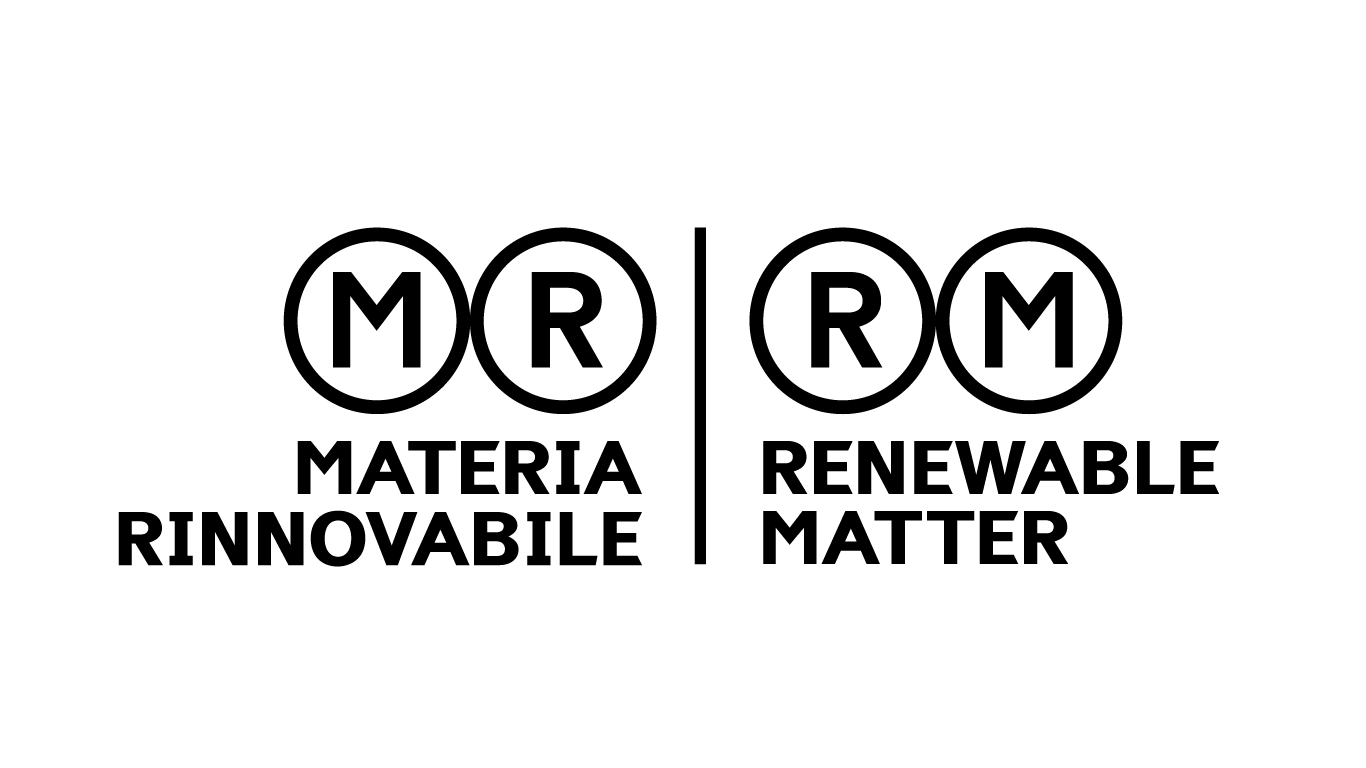Certo, non tutti gli oggetti circolanti erano il frutto di una mente progettante: molto design anonimo (si veda la mostra “Hidden forms” tenutasi nel 2014 alla Triennale di Milano) ha compiuto eccellenti intrusioni nella nostra vita, ma “dal cucchiaio alla città” i designer molto hanno potuto.
Ed è stato questo molto – più di qualsiasi rivoluzione industriale – che ha trasformato la vita umana: le piccole e grandi innovazioni disponibili negli Usa nella prima metà del Novecento hanno generato un incredibile aumento del benessere e della qualità della vita.
Le voci critiche che si sono sollevate a partire dagli anni Settanta – basti pensare a giganti come Victor Papanek ed Enzo Mari – sono rimaste confinate in un’area intellettuale, all’interno di un dibattito culturale destinato a pochi. Poi negli anni Ottanta, stanchi e consumati dal “tutto” che era stato disegnato, i designer si sono presi la briga di ridisegnarlo. In quegli anni il mercato dell’offerta non si poneva molte domande, chiedeva quasi solo forme: questo doveva fare il design. Il diktat era interpretare la forma, che doveva essere seduttiva e meravigliare: una fiera delle vanità neppur lambita dai primi dibattiti in Italia e in Europa sui limiti dello sviluppo. Il progettista agiva indisturbato inventando superfici sensuali e setose, mistificando la materia, rendendo cool qualsiasi tipo di impiallacciatura e pattern. Così il nostro universo materico è diventato sempre più misto, frammisto e confuso. L’economia però girava: generava deficit e debiti pubblici, ma girava e nessuno si faceva domande.
 La nascita del dubbio
La nascita del dubbio
I primi dibattiti sulla raccolta differenziata dei materiali – risalenti a circa 20 anni fa – si sono posti anche come un tentativo, raramente compreso fino in fondo, di semplificare una realtà obesa, onnivora e quindi complessa.
Nel mentre sono arrivate le direttive sui rifiuti a cambiare la faccia delle politiche pubbliche e delle responsabilità anche private in materia di gestione rifiuti (che ancora non si chiamavano risorse). In particolare fu il Libro verde sulle politiche integrate di prodotto (Ipp) del 2001 a chiamare in causa l’importanza del ciclo di vita e quindi il valore dell’ecodesign.
In effetti, già dalla fine degli anni Novanta l’Europa ha richiamato a una riflessione basata sulla necessità di integrare le politiche ambientali per migliorare prodotti e servizi nell’arco del rispettivo ciclo di vita. Il nodo era come ottenere, nel modo più efficiente possibile, prodotti più ecologici: allora si parlava molto di rivoluzione imminente prodotta dai materiali riciclati che si proponevano di entrare nella nostra vita come rimateria e come farli utilizzare dai consumatori.
Per sperare in un futuro più luminoso – e meno gravido di conseguenze da gestire – la partita da giocare era quella. Ma purtroppo i designer che si accostavano a quel tema erano pochissimi perché gli imprenditori attivi in quel mondo e capaci di ricorrere a loro erano radi; il design era un concetto ancora esotico e quindi i green product erano a quel tempo brutti, pochi, poveri e spesso anche troppo di sinistra.
Non avevano appeal, erano ideologici. E neppure democratici visto che costavano troppo e poche volte alla portata dei portafogli dei più.
È però negli anni Novanta che si inizia a chiedere al designer un nuovo compito: progettare nuovi processi e servizi ecologici, non più solo di prodotti. Con la fine dell’edonismo reaganiano, il designer ha l’opportunità di reinventarsi – nel ruolo e funzione – in chiave sostenibile. E per passare dal prodotto al servizio trova in Ezio Manzini il suo più noto profeta.
Sono gli anni in cui di fatto emetteva i primi vagiti la necessità di esprimere creatività non solo nel progettare merci, ma anche percorsi, interazioni, reciprocità, nuovi paradigmi e funzioni sostenibili.
Oggi i principi dell’ecodesign definiti per i prodotti legati al consumo di energia o all’efficienza energetica (Direttiva 2009/125/CE) appaiono letteratura. Tuttavia, seppur scontati e incapaci di fare notizia, la loro applicazione consentiva e consente grandi benefici per l’ambiente e il portafoglio. E le best practices, che 10-15 anni fa erano poche decine, si sono sempre più consolidate nelle imprese: lo dimostrano i programmi formativi che via via proliferano, i dibattiti in Commissione europea, a livello nazionale e persino locale.
La green economy, ora circular economy, ha accresciuto il numero di addetti che impiega: secondo stime della Commissione Ue i posti di lavoro in Europa nel settore sono arrivati a 400.000.
Circular significa capacità di produrre e consumare merci in modo da generare una ricchezza che non si disperde, che non genera output inservibili e che rigenera e usa tutto quello (o quasi) che trova sul suo tracciato.
Un’economia autotrofa che trova radici e creatività (anche nel suo dispiegarsi) nella recente crisi.
Ma, quasi contemporaneamente, entra in scena la terza Rivoluzione industriale, ovvero la società digitale. Quella destinata a disintermediare con sempre più disinvoltura i codici della produzione, quella che smaterializza la conoscenza per poi riaggregarla secondo altri paradigmi, disegna un futuro sfidante e impensabile fino all’altro ieri.
Da una parte, quindi, la crisi, che rende vantaggioso il ricircolo della materia rigenerando anche l’idea di economia del dono e dei servizi. Dall’altra l’innovazione del digitale, che permea il mondo con bit al posto di materia.
Il ruolo del designer diventa allora sempre più centrale perché, insieme e grazie ai nuovi imprenditori, deve dare forma al cambiamento... altro che solo crudi prodotti!
Alcuni designer riescono a farlo diventando autoproduttori, altri portando ecoinnovazione (talvolta anche digitale) nelle imprese tradizionali, spesso progettando processi di accesso ai beni invece che possesso. Altri ancora operando nel sociale ridisegnando relazioni e interazioni il cui teatro sono i contesti urbani e gli attori sono la società civile, oggi alla ricerca di articolazioni e relazioni più contemporanee.

Il fare circolare
E quali sono i principali criteri distintivi della circular che orientano oggi il “fare” dei designer?
Nel caso dell’autoproduzione, la capacità di usare risorse locali che viaggiano poco (e quindi inquinano poco) e diventano espressione di territorialità che è uno dei cardini su cui si basa la circular. Se poi tali risorse sono scarti di produzione, quindi di processi che trovano un possibile reimpiego nel prodotto e nell’autoprodotto, si attua uno dei principi più cari alla circular economy: la simbiosi industriale.
Il riuso si può praticare ogni volta che un materiale presenta caratteristiche di ri-lavorabilità senza perdere performance prestazionali, anzi migliorando il suo valore (upcycling). E suona come una svolta anche culturale perché di fatto tali processi si affidano a mani artigianali, a tirature limitate, che sempre più sdoganano l’imperfetto, rinunciando all’odiosa chirurgia estetica.
Alla circular piace anche lo sharing di risorse, tecnologie e conoscenza perché tutto ciò che è condivisione ottimizza spesso i processi di produzione e genera efficienza; i designer sono stati pionieri nel condividere attrezzature, creatività e risorse.
E pensare allo sharing di stampanti 3d (con i fablab, i service 2.0 ecc.) fa pensare che un altro comune denominatore tra prodotto/designer e circular è proprio il mondo della stampa tridimensionale che semplifica i processi (si abbrevia la progettazione, sviluppo e time-to-market), usa materia misurata (no scarti), può funzionare con alimentazione da energia rinnovabile, impiegare materia riciclabile, generare componenti aggregabili ma separabili dagli altri... e soprattutto favorire la riparazione puntuale.
Quindi la 3dprint, di cui molti maker sono innamorati, abilita la manutenzione/riparazione delle merci generando una ricambistica di supporto laddove quella standard fosse inesistente o inaccessibile.
Potrebbe essere uno dei più grandi driver nemici dell’obsolescenza programmata e quindi può piacere molto a chi crede in un futuro che rigenera beni invece che cannibalizzarli in eterno. Ma la 3d è circolare anche laddove riesce a usare risorse locali (evitando rischi di approvvigionamento di materia volatile o geopoliticamente fragile) e i designer sono cellule sensibili al territorio, capaci più di altri di cogliere sfumature sociali, interpretandole con elasticità spesso meglio di un’impresa strutturata.
Pillole di ecodesign
I principi dell’ecodesign definiti nell’allegato I della Direttiva 2009/125/CE (ERP – Energy Related Products) prevedevano:
- minimizzazione del consumo di materiali ed energia > minor produzione di rifiuti e minor uso di risorse
- riduzione dell’uso di sostanze pericolose > output di processo e consumo qualitativamente meno inquinanti e dannosi
- facilità di reimpiego e riciclaggio del prodotto > minor produzione di rifiuti a parità di prestazione
- utilizzo di risorse rinnovabili, biocompatibili e locali > effetti sia sulla quantità sia sulla qualità dei rifiuti generati
- ottimizzazione della vita dei prodotti (quindi loro estensione) attraverso una facile aggiornabilità, manutenzione e una scarsa obsolescenza funzionale > minor produzione di rifiuti a parità di prestazione nel tempo
- semplificazione delle operazioni di disassemblaggio del prodotto > miglioramento nella differenziazione delle tipologie di rifiuto e conseguente aumento della sua qualità
Rigenerare una comunità, non solo un prodotto
Senza dimenticare, poi, il ruolo social del design. In tal senso è illuminante il percorso di Alvaro Catalàn de Ocòn. Con le sue Pet Lamp ci insegna che le tradizioni locali, massimo e magistrale esempio di autoproduzione, possono ancora rinnovarsi sotto l’ombrello di un’autoproduzione moderna e intelligente. Cioè non sono necessariamente destinate a restare polverose, antiquate o kitsch come talvolta accade nel nostro immaginario. Tutt’altro, forme archetipe si possono riconnotare grazie al global (rifiuti di bottiglie in Pet presenti ovunque) che si integra così con il local, restituendo un diverso senso a chi le fa (e conosce da sempre), rigenerando una comunità e un mestiere, non solo un prodotto.
Il potere della progettazione è anche questo: rigenerare un mestiere, assumere e svolgere così un ruolo sociale. E anche questo fattore è aderente alla circular economy perché va nella direzione dell’ottimizzazione delle risorse: quelle umane/sociali.
Infine a tale riguardo non si può non citare la rivoluzione degli hub, poli/aggregatori di creatività diffusa e di nuove identità solidali. Qui si ricorre ai designer ancor meno che per progettare materia bensì per riprogettare i processi e le relazioni sui territori, inventare formule nuove per stimolare e convogliare creatività e risorse, pensare in modo disruptive e per questo più capaci di immaginare un futuro.
E quando a un designer di prodotto chiediamo di parlare di ecodesign o se si riconosce attento alla sostenibilità la risposta è: “È roba da secolo scorso! Oggi se non hai un approccio anche eco al progetto, non esisti!”
Accessori per la tavola Leuvehaven
Progetto di Sebastiano Tonelli sviluppato a Rotterdam nell’ambito di un Erasmus presso la Willem de Kooning Academie.
Sebastiano Tonelli si è laureato nel 2015 con “collezione 25%” alla Naba di Milano, dove ha conseguito il triennio in design e il biennio specialistico in Product Design.
Leuvehaven scaturisce dal confronto culturale con l’artigianato locale e i suoi prodotti: in Olanda è infatti ancora molto forte il richiamo al ricamo e al mondo della pesca. Leuvehaven nasce dal recupero iconico di questa tradizione e delle reti da pesca impiegate.