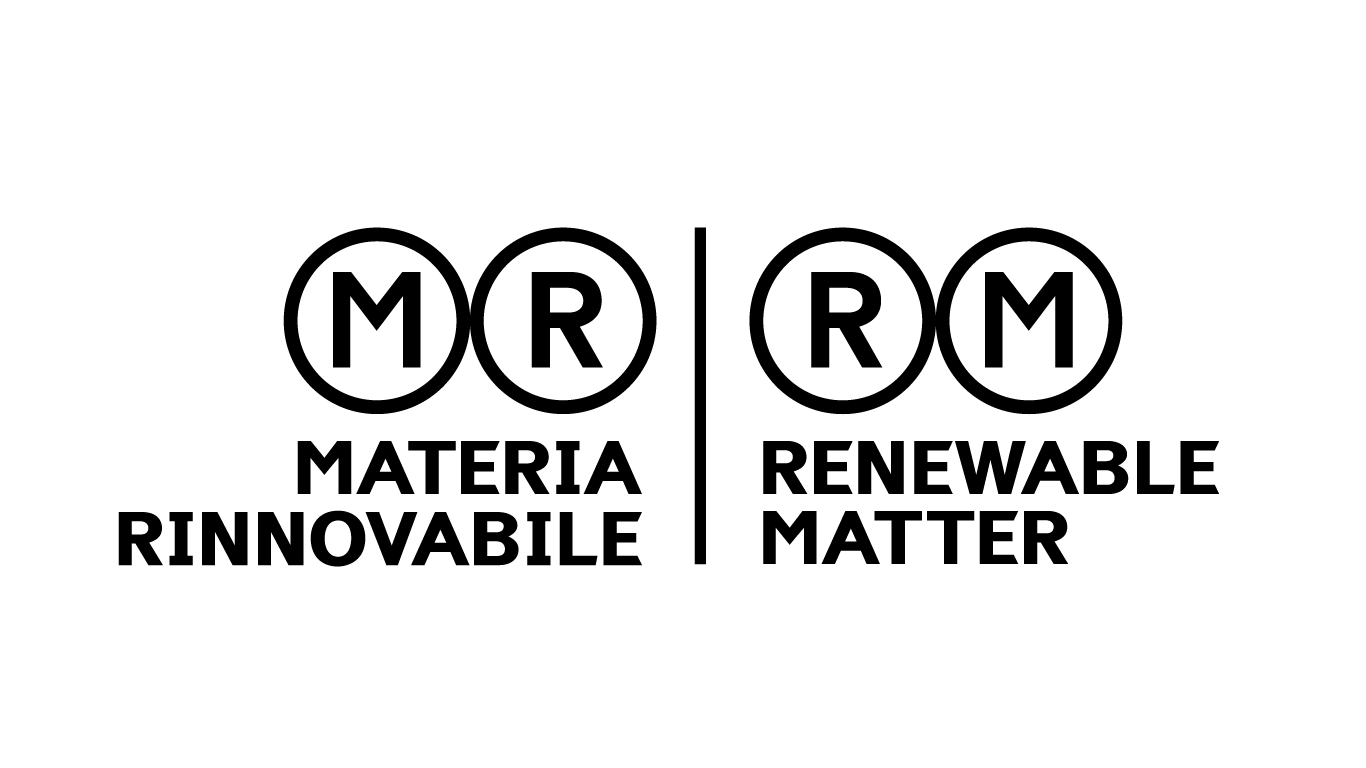Questo vuol dire che non si può più progettare lo sviluppo a tavolino, con formule anonime da replicare, con poche varianti, in tutto il pianeta. La bioeconomia, l’economia che integra le risorse della biosfera e quelle dell’ingegno umano, si fonda sulla conoscenza e sul rispetto del territorio e delle sue particolarità. Solo una conoscenza profonda delle possibilità e dei bisogni di ogni singolo luogo, unita a una ricerca continua per utilizzare nel modo più efficiente le risorse che possono essere rese disponibili, senza creare squilibrio, permette di impostare uno sviluppo che tenga assieme le ragioni dell’economia, dell’ambiente e di chi abita il territorio.
Si tratta, per esempio, di insediare tecnologie avanzate non in luoghi ad alta vocazione agricola o turistica, ma in siti che subiscono i contraccolpi della deindustrializzazione e che possono scegliere una nuova opportunità: un’integrazione innovativa tra il mondo dell’agricoltura e quello dell’industria. Non con progetti che calano dall’alto e concentrano le attività in un’unica grande impresa, ma con un modello a rete in cui l’impresa fa da catalizzatore per un grande numero di iniziative diffuse: cooperative di giovani agricoltori che si organizzano per fornire la materia prima, altre strutture imprenditoriali che seguono il processo nelle varie fasi, immaginando di utilizzare i materiali prodotti come soluzioni operative per risolvere problemi, fornire servizi, aumentare la qualità della vita.
Materiali che devono essere studiati per ridurre l’impatto ambientale del loro uso, assicurando un vantaggio per tutti e una capacità competitiva per la collettività, che si riconosce nel progetto e si impegna per il suo successo. Penso per esempio ai prodotti innovativi che oggi incominciamo a essere in grado di produrre in settori che vanno dalla lubrificazione (migliorando le prestazioni ed evitando i rischi di inquinamento di acqua e suolo connessi a prodotti derivati del petrolio non in grado di biodegradare) ai plastificanti per polimeri, derivanti da fonte rinnovabile e privi di rischi, in sostituzione degli ftalati (oggetto di osservazione per gli effetti sul sistema endocrino); dagli pneumatici (che assicurano minore resistenza al rotolamento, diminuendo i consumi) alla cosmesi; dagli antiossidanti agli erbicidi naturali.
Si tratta di mettere a sistema il territorio, l’università, i centri di ricerca, le persone impegnate su questi temi per creare un effetto moltiplicatore dei benefici, a partire dal rilancio dell’occupazione. È un modello che permetterebbe di evitare gli errori del passato (ruolo eccessivo di sostegno della finanza pubblica a produzioni non più competitive e con impatto ambientale elevato, che finisce per alimentare rendite di posizione, interventi “spot” senza una strategia complessiva, che disincentiva lo sviluppo virtuoso, finendo per aumentare l’import commerciale e per generare nuova disoccupazione), garantendo una regia del territorio per il governo delle sue potenzialità per la bioeconomia. In questo modo, oltretutto, si potrebbero ripensare approcci non sostenibili come gli incentivi settoriali e indiscriminati, senza una logica di sistema in comparti con enormi volumi.
Non sono solo progetti per il futuro. La vicenda degli shopper biodegradabili e compostabili, collegati alla trasformazione del problema del rifiuto organico in risorsa, dimostra che l’Italia è in grado di elaborare – dal punto di vista ideativo, scientifico, organizzativo e politico – modelli che risultano vincenti sul piano della competitività e del consenso internazionale. Ciò che è stato fino a ora costruito è stato possibile perché si è instaurato un dialogo fecondo tra ricercatori, ambientalisti, cittadini, politici, organizzazioni industriali. E perché abbiamo dato al paese un’opportunità per risolvere vari problemi: dal rilancio occupazionale (da dati Plastic Consult, a oggi questa filiera occupa più di 1.500 persone, gli operatori sono circa 150 e il fatturato è di 450 milioni di euro e potrebbe essere di un miliardo combattendo l’illegalità; l’implementazione completa della filiera a monte delle bioplastiche potrebbe giustificare 6.000 posti di lavoro diretti, e se il modello si estendesse all’Europa si salirebbe ad alcune decine di migliaia di occupati), alla diminuzione dell’impatto ambientale (Milano in un paio d’anni è diventata leader mondiale della raccolta differenziata dell’organico per quantità e qualità). È la dimostrazione che dalla crisi si esce solo con formule nuove che mettano al centro gli interessi dei cittadini, partendo dalla sperimentazione sul territorio di progetti sistemici.